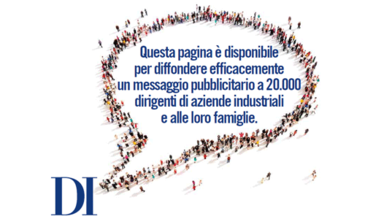Rifiuti domestici. Forse non tutti sanno che…
Vizi e virtù della raccolta differenziata. Un dato spicca: quasi il 22% della frazione umida raccolta in modo differenziato viene buttata nuovamente umida raccolta in modo differenziato viene buttata nuovamente perché contaminata da sostanze improprie in conseguenza dei nostri comportamenti perché contaminata da sostanze improprie in conseguenza dei nostri comportamenti e anche per inadeguatezza degli impianti di trattamento e anche per inadeguatezza degli impianti di trattamento

Foto di Cuenta Miyago da Pixabay
Giorgio Venturino
Socio ALDAI-Federmanager Presidente Gruppo Ecologia
Rifiuti solidi urbani (RSU)
Le frazioni merceologiche in cui viene normalmente suddivisa la raccolta dei rifiuti domestici per la raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, plastiche e imballaggi, legno, metalli, umido. Ad esse vanno poi aggiunte altre categorie di rifiuti che domestici non sono e che rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali (prodotti cioè da attività umane non domestiche), quali per esempio: rifiuti elettrici ed elettronici, farmaci scaduti, olii esausti, pile e batterie, prodotti chimici, che non possono essere smaltiti con quelli domestici. Rifiuti come quelli prodotti da attività commerciali (uffici) e quelli derivati da attività di ristorazione sono invece considerati assimilabili e possono invece essere smaltiti insieme a quelli urbani.
Per ogni tipo di frazione merceologica esistono in Italia vari consorzi per il riciclo come per esempio: Conai e Corepla per imballaggi e plastiche, Comieco per carta e cartoni, Coreve per vetro, Rilegno per legno, Cial per alluminio, Ricrea per acciai, il CDC Raee per rifiuti elettrici ed elettronici, Conou per gli olii esausti, Cobat per batterie, CDCN PA per pile e accumulatori, ecc.
Va sottolineato che, mentre i rifiuti urbani sono raccolti direttamente nelle abitazioni tramite la società delegata dal comune competente per territorio, i rifiuti speciali vanno invece portati nella ricicleria autorizzata più vicina e non possono essere mescolati insieme agli altri.
Va inoltre ricordato che laddove sussistano dubbi o incompatibilità nella suddivisione tra le varie frazioni al momento della suddivisione, esiste sempre un’ulteriore frazione a cui far ricorso senza timore di sbagliare: l’indifferenziato, che è destinato alla termovalorizzazione. A tale destinazione è bene orientarsi quando il rifiuto da smaltire è costituito da polimateriali non facilmente separabili tra loro come gli ICP (imballaggi compositi poliaccoppiati), oppure quando pur rientrando in una certa frazione merceologica quel tipo particolare di rifiuto presenta caratteristiche chimico-fisiche che non si adattano alla tecnologia di riciclo della frazione principale. È questo, per esempio, il caso (nella filiera del vetro) del pyrex, dei cristalli, degli specchi, delle lampadine, o (nella filiera della carta) della carta chimica, della carta oleata, della carta plastificata.
In ultima analisi la raccolta differenziata è finalizzata a selezionare e riciclare solo quelle correnti di rifiuto che una volta trattate hanno un mercato e vengono reimmesse nel ciclo produttivo, diversamente essa non fa che aumentare il costo di smaltimento dei rifiuti.
Dovendo quindi tener presenti le tecnologie disponibili per il riciclo delle varie frazioni merceologiche recuperate è evidente che l’esecuzione ottimale della raccolta differenziata non è alla portata di tutti perché richiede un supporto di informazioni tecniche che la popolazione normale può difficilmente acquisire: a tale carenza dovrebbe subentrare da parte dei comuni la raccolta “porta a porta” o l’invio sistematico di istruzioni dettagliate.
Ci sono inoltre due categorie merceologiche di rifiuti che possono presentare nella suddivisione domestica numerose incertezze per conseguire una raccolta differenziata efficiente: l’umido (Forsu - Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e le plastiche. Di questi aspetti parleremo ora.
L’umido
Occorre premettere una differenza importante tra concime ed ammendante: il concime nutre la pianta, mentre l’ammendante nutre il terreno. Il concime può essere organico (letame e stallatico, guano, scarti di origine animale, pollina, sangue secco, farina d’ossa) o inorganico (fertilizzanti chimici NPK come sali azotati, fosfatici, potassici), così come anche l’ammendante può essere organico (compost, scarti agricoli, torba, humus) o inorganico (calce, gesso, pomice).
L’ammendante aumenta la porosità del terreno e la ritenzione idrica, aumenta il tenore di carbonio nel suolo, la formazione di humus, e l’attività dei microrganismi che decompongono la sostanza organica.
Un’altra differenza importante è quella tra materiale biodegradabile (che subisce tramite adeguati trattamenti la decomposizione biologica) e materiale biogenico prodotto cioè da organismi viventi in epoca recente (non di origine fossile) che è assimilato a rinnovabile: questa seconda categoria costituisce la biomassa del pianeta.
Ogni materiale biologico subisce una biodegradazione temporale naturale che può però essere anche molto diversa, come quella tra la lignina (legno: alcuni anni), la cellulosa (carta: alcuni mesi), e i residui di origine agricola (l’umido: alcune settimane). La Forsu ricavata dall’umido può essere avviata a processo di degradazione aerobica per il tempo necessario al compostaggio (con impiego di aria) oppure a processo di degradazione anaerobico per la durata necessaria (in fase liquida, in assenza di aria, e a temperatura costante di circa 30-50 °C) a produrre biogas (CH4+CO2) e digestato semisolido da compostare. Il compostaggio in entrambi i casi avviene in parchi areati e movimentati in continuazione, dove la sostanza biodegradabile permane per circa 6 settimane con produzione di odori dovuti alla fermentazione e che devono essere quindi eliminati.
La digestione anaerobica avviene invece in grandi reattori chiusi (digestori) dove la fase liquida (in cui è diluita la Forsu precedentemente sfibrata e triturata) è continuamente riciclata per circa 4-5 settimane con rilascio nella parte superiore del biogas. Il biogas è già combustibile ma deve essere depurato e separato della CO2 per ottenere CH4 rinnovabile.
Il compost è un ammendante che può essere di buona o di cattiva qualità in relazione a quella originale della Forsu. Correnti verdi preselezionate provenienti da scarti agricoli e di giardino, come pure da rifiuti organici raccolti da ristoranti e mercati ortofrutticoli con tempi di degradazione omogenei garantiscono Forsu e quindi compost di buona qualità vendibile perché ammendante richiesto in agricoltura, mentre l’organico proveniente dalla raccolta cittadina dell’umido o dall’umido prodotto dagli impianti TMB (trattamento meccanico-biologico) per il trattamento del rifiuto tale e quale che può contenere tenori importanti di impurezze come microplastiche, vetro fine, sostanze inquinanti e metalli pesanti (lasciati impropriamente nel sacchetto di plastica dell’umido al conferimento) produrranno poi un compost che nessun agricoltore desidera spargere sul proprio terreno. Questo compost può solo servire come terra di ricoprimento nelle discariche di rifiuti da bonificare.
La qualità e la quantità di umido raccolte sono inoltre legate anche a fattori culturali, sociali e geografici della popolazione residente: quella di campagna produce scarti più omogenei e di provenienza locale, mentre quella cittadina risente di un’entropia in aumento per scarti di diversa provenienza con elevata presenza di imballaggi.
La qualità e la quantità di umido raccolte sono inoltre legate anche a fattori culturali, sociali e geografici della popolazione residente: quella di campagna produce scarti più omogenei e di provenienza locale, mentre quella cittadina risente di un’entropia in aumento per scarti di diversa provenienza con elevata presenza di imballaggi.
Le plastiche
La plastica non esiste ma ci sono 48 monomeri organici non biogenici (che possono essere di origine fossile o rinnovabile) con biodegradabilità che non dipende dalla molecola originaria, ma dalla struttura molecolare della catena polimerica finale. Le bioplastiche sono di origine vegetale e sono pertanto degradabili e compostabili da parte di microrganismi, mentre le plastiche di origine fossile non sono degradabili e compostabili.
Il riciclo separato per monomero per essere venduto viene rifuso e granulato fino a circa 2-4 mm, tenendo presente che le caratteristiche meccaniche del prodotto riciclato sono diverse se ottenute con polimero vergine, con polimero riciclato, o rifondendo insieme polimeri di monomeri diversi che non si legano tra loro.
In pratica per ogni riciclo si ha una perdita del 10% di tali proprietà per cui dopo circa 5 ricicli il polimero può considerarsi esausto, non riciclabile, e da smaltire diversamente. Si ricorda che le plastiche contengono anche cloro e se bruciate all’aperto producono diossine.
In pratica per ogni riciclo si ha una perdita del 10% di tali proprietà per cui dopo circa 5 ricicli il polimero può considerarsi esausto, non riciclabile, e da smaltire diversamente. Si ricorda che le plastiche contengono anche cloro e se bruciate all’aperto producono diossine.
Un problema molto serio è inoltre costituito dal degrado delle plastiche abbandonate sul territorio e in mare, e dai reflui rilasciati da alcune industrie della cosmesi e dei detergenti che danno origine alle microplastiche (non trattenute per le loro dimensioni dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane se non con l’introduzione di membrane di microfiltrazione) che nel lungo periodo si infiltrano nella catena alimentare con danni irreversibili sulla nostra salute.
Secondo la classificazione della Society of Plastic Industry ci sono solo 6 tipi di polimeri termoplastici riciclabili che hanno un mercato: Pet (polietilene tereftalato), Ldpe (polietilene a bassa densità), Hdpe (polietilene ad alta densità), Pvc (polivinilcloruro), Pp (polipropilene), Ps (polistirene). Gli imballaggi sono riciclati con i contributi del Conai versati dai produttori.
La selezione della raccolta differenziata delle plastiche riciclabili viene fatta tramite linee di trattamento ad elevata automazione che prima separano tra loro le diverse frazioni e dopo lavorano sulle singole frazioni separate. Esse comprendono vagli, separatori balistici e di metalli, e sensori ottici NIR che sfruttano la diversa riflessione della radiazione infrarossa.
Tutti gli altri monomeri (plastiche di tipo 7) essendo prodotti in quantità troppo limitata non hanno mercato e non sono riciclabili, come pure tutte le platiche recuperate dall’indifferenziato, le plastiche termoindurenti, le plastiche scartate durante il riciclo, le plastiche esauste. Tutte queste plastiche non riciclabili che sono quasi il 50% di quelle originarie, una volta raggruppate costituiscono il Plasmix e possono essere smaltite solo negli impianti di termovalorizzazione unitamente al Combustibile Solido Secondario prodotto dalla frazione secca degli impianti TMB (trattamento meccanico biologico dei RSU).
Ciò dimostra la complementarità necessaria tra la raccolta differenziata per il recupero di materia e la termovalorizzazione per il recupero di energia dalla frazione che non è riciclabile.
Il problema delle plastiche resta oggi il più difficile e complesso nella gestione dei rifiuti e una nuova normativa più restrittiva sul tema da parte della UE potrebbe aiutare a fare chiarezza.
01 giugno 2025
 Localizza
Localizza 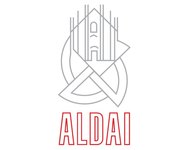




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp