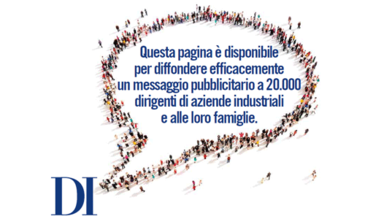Il merito e l’Italia: 10 anni di opportunità mancate
Nel 2024, il Meritometro suona l’ennesimo campanello d'allarme: l'Italia è ferma. Ultimi in Europa - da dieci anni - per meritocrazia e attrattività dei talenti, continuiamo a perdere risorse preziose e opportunità di crescita. Il debito meritocratico non si riduce e il futuro si fa incerto. Come cambiare rotta?

Giorgio Neglia
Manager esperto di sistemi formativi, Consigliere Forum della Meritocrazia Responsabile Meritometro e Meritorg
Il Meritometro, strumento di analisi del merito in Europa, sviluppato dal Forum della Meritocrazia in collaborazione con l'Università Cattolica, giunge alla decima edizione. Basato su dati provenienti da fonti internazionali, l’indicatore classifica i Paesi europei in funzione delle performance ottenute rispetto ai sette pilastri del merito: libertà, pari opportunità, qualità del sistema educativo, attrattività per i talenti, regole, trasparenza e mobilità sociale.
L'edizione 2024, presentata a Milano lo scorso 6 febbraio in occasione della Giornata Nazionale del Merito, offre una fotografia preoccupante dell’andamento del merito nel nostro Paese rispetto ai principali partner comunitari.
Europa: un continente a tre velocità
L'analisi, che coinvolge 12 Paesi rappresentanti l'80% della popolazione europea, evidenzia un continente a diverse velocità, con performance complessive sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno. Questo a conferma di un periodo denso di incertezze derivanti dal contesto geopolitico e dalle sfide che il vecchio continente sta affrontando a fronte della crescente competizione internazionale e della twin transition. In questo quadro, il ranking del Forum della Meritocrazia consente di identificare tre gruppi di Paesi. Al vertice troviamo, saldamente al comando, quelli scandinavi. Nel gruppo intermedio si collocano Germania, Francia e Gran Bretagna. Chiudono la classifica i Paesi mediterranei, con l'Italia in ultima posizione, preceduta dalla Spagna.
Italia: la “grande immobilità” che porta i talenti a fuggire

L’Italia, con 27,06 punti su 100, conferma la maglia nera e gap significativi rispetto alle medie comunitarie nei pilastri riguardanti la libertà economica, le regole, la trasparenza e l'attrattività per i talenti. Il nostro Paese è penalizzato da una burocrazia invasiva e farraginosa, un sistema giudiziario inefficiente e un carico fiscale elevato che scoraggia investimenti e innovazione. Per giunta, la mobilità sociale è bloccata: il futuro dei giovani dipende ancora troppo dalle risorse familiari, e l'ascensore sociale è praticamente fermo, con una classe media sempre più preoccupata per il futuro.
Non sorprende che in una tale situazione di stagnazione, che caratterizza un Paese affetto dalla sindrome della medietà, come lo ha definito il Censis nel suo ultimo rapporto, le risorse più valide e vitali cerchino la valorizzazione dei propri talenti in contesti più meritocratici. Il dato più recente sulla fuga dei cervelli viene dalla Fondazione Nord Est: tra il 2011 e il 2023 circa 550.000 italiani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato il Paese, con un saldo netto di 377.000 partenze. L'85% di chi è espatriato ritiene che la meritocrazia sia minore in Italia rispetto ai Paesi di destinazione. Questo vero e proprio esodo di talenti rappresenta una perdita di capitale umano stimata in 134 miliardi di euro.
Timidi segnali di miglioramento e pesanti criticità strutturali
Nonostante il quadro complessivo sia desolante, le performance meritocratiche italiane sono aumentate rispetto allo scorso anno di 0,66 punti. Risultato frutto di leggeri miglioramenti nei pilastri delle pari opportunità e della qualità del sistema educativo. Progressi comunque insufficienti per colmare il divario con gli altri Paesi europei.

La percentuale di giovani NEET, sebbene diminuita, ci posiziona agli ultimi posti in Europa. Anche sul fronte della condizione femminile, l'Italia mostra criticità significative. Per il Gender Equality Index dell’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) siamo 14esimi, sotto la media europea e ultimi per partecipazione femminile al lavoro e opportunità di carriera. Nonostante i miglioramenti delle performance del sistema educativo, l'Italia rimane indietro in termini di educazione terziaria (30,6% contro una media UE del 43,1%) e di abbandono scolastico (9% contro l'8,2% della media UE).
Una riflessione a parte merita l’analisi delle performance meritocratiche del nostro Paese negli ultimi dieci anni. Nel complesso, dal 2015 al 2024, il punteggio dell’Italia nel ranking comunitario è cresciuto di 4,68 punti, una misura non sufficiente a erodere lo stock di debito meritocratico accumulato negli anni.
Le opportunità mancate: produttività, benessere, soddisfazione



Il basso livello di meritocrazia in Italia ha profonde ripercussioni sulle performance economiche e sociali del Paese. I dati mostrano una correlazione tra merito e produttività: ad esempio, nei Paesi scandinavi, ai vertici del ranking meritocratico, la produttività del lavoro (PIL per ora lavorata) è in media superiore di circa un terzo rispetto a quella italiana. Una maggiore produttività si traduce in una maggiore competitività, in un aumento degli investimenti e in una migliore occupabilità.
Ma i problemi non si limitano all’economia. Il Rapporto sul benessere sostenibile e inclusivo del Joint Research Centre della Commissione Europea dipinge un quadro preoccupante. L’Italia registra ampi divari di genere nell’occupazione, una forte disuguaglianza dei redditi e un sistema istituzionale inefficiente. Inoltre, le risorse per il futuro – capitale economico, umano e sociale – sono ferme ai livelli del 2011, compromettendo le prospettive delle nuove generazioni.
Questa situazione si riflette in un livello di fiducia e soddisfazione tra i più bassi d’Europa. Secondo l’ultima indagine Eurofound sulla qualità della vita, gli italiani sono i meno ottimisti del continente e si collocano al di sotto della media comunitaria per soddisfazione complessiva delle proprie condizioni di vita.
I nodi irrisolti: scarsa attrattività, mobilità limitata e burocrazia eccessiva frenano la crescita e l'innovazione.
L'analisi indica una società che galleggia e perde talenti: l'Italia soffre della "sindrome della medietà" (Censis, 2024), un immobilismo che spinge i talenti a emigrare verso paesi più meritocratici, impoverendo il futuro del Paese.
Cosa fare per cambiare rotta
Per ridurre il debito meritocratico italiano è necessario intervenire su più fronti. Il primo è rinnovare il contesto, creando regole più chiare e trasparenti. Un quadro normativo più semplice ed efficiente non solo rafforza la fiducia di investitori e cittadini, ma stimola l'innovazione e previene pratiche corruttive. Bisogna poi continuare a investire per migliorare il sistema educativo, perché dalla qualità del capitale umano dipendono sempre più le possibilità di crescita del Paese e creare, attraverso politiche mirate e strutturali, condizioni favorevoli alla mobilità sociale e all'attrattività per i talenti.
Ma non basta, è indispensabile agire anche dal "basso". La promozione del merito deve partire dalle fondamenta: scuole, aziende e pubblica amministrazione sono chiamate a diventare laboratori dove talenti e competenze possano fiorire. Questo richiede non solo strategie appropriate, ma un vero e proprio cambio di paradigma culturale. Il management riveste un ruolo determinante in questo processo, facendosi promotore attivo del cambiamento favorendo la creazione di ambienti di lavoro dove trasparenza, inclusione e meritocrazia non siano solo slogan, ma prassi quotidiane.
Questa trasformazione richiede un'azione coordinata e sistematica. L'Italia non può più permettersi l'approccio frammentario ed emergenziale che l'ha caratterizzata finora. Le sfide che ci attendono richiedono una visione sistemica e di lungo periodo, dove ogni attore - istituzioni, imprese, parti sociali e cittadini - è chiamato a fare la propria parte in modo sinergico. Solo attraverso questa collaborazione potremo costruire un ecosistema dove il merito non sia un'aspirazione, ma il fondamento su cui edificare un futuro di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile.
01 marzo 2025
 Localizza
Localizza 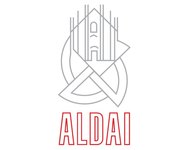




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp